
 In Occidente chi per primo si è interrogato sul compito della pena son stati i greci. Guarda caso, già allora, erano presenti due concezioni diametralmente opposte: vi era chi la immaginava come strumento retrospettivo (o meglio, retributivo), cioè infliggere un male, in cambio del male fatto, invece per altri era strumento prospettivo, cioè si doveva pensare al futuro e non al già trascorso.
In Occidente chi per primo si è interrogato sul compito della pena son stati i greci. Guarda caso, già allora, erano presenti due concezioni diametralmente opposte: vi era chi la immaginava come strumento retrospettivo (o meglio, retributivo), cioè infliggere un male, in cambio del male fatto, invece per altri era strumento prospettivo, cioè si doveva pensare al futuro e non al già trascorso.
12marzo 2015 di Ennio Succi
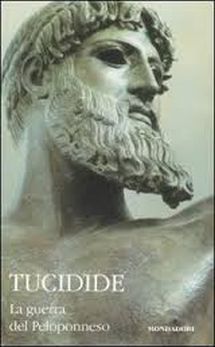 Testimonianza di ciò si ha in Tucidide che nella Guerra del Peloponneso, circa nel 430 a.C., ci narra che i cittadini di Mitilene ribellatisi ad Atene furono sconfitti. Gli ateniesi dovevano, allora, infliggere loro una pena, ma erano in discordia. Cleone rappresentava la voce di quegli ateniesi che volevano uccidere gli uomini, vendere donne e bambini come schiavi, e che tutto questo fosse fatto subito, lungo l’onda emotiva del tradimento di Mitilene verso Atene. “[…] “Pensate bene a quello che avete dovuto subire” dice Cleone agli ateniesi. Questo servirà anche da esempio agli altri alleati che sapranno quel che accadrà se si ribelleranno”. (Eva Cantarella, I supplizi capitali in Grecia e a Roma. Origini e funzioni delle pene di morte nell’antichità classica, Feltrinelli, Milano 2011, p. 75).
Testimonianza di ciò si ha in Tucidide che nella Guerra del Peloponneso, circa nel 430 a.C., ci narra che i cittadini di Mitilene ribellatisi ad Atene furono sconfitti. Gli ateniesi dovevano, allora, infliggere loro una pena, ma erano in discordia. Cleone rappresentava la voce di quegli ateniesi che volevano uccidere gli uomini, vendere donne e bambini come schiavi, e che tutto questo fosse fatto subito, lungo l’onda emotiva del tradimento di Mitilene verso Atene. “[…] “Pensate bene a quello che avete dovuto subire” dice Cleone agli ateniesi. Questo servirà anche da esempio agli altri alleati che sapranno quel che accadrà se si ribelleranno”. (Eva Cantarella, I supplizi capitali in Grecia e a Roma. Origini e funzioni delle pene di morte nell’antichità classica, Feltrinelli, Milano 2011, p. 75).
C’era però un’altra posizione, quella di Diodoro, che incalzava dicendo che fretta e ira sono il maggior nocumento in una decisione saggia e la deterrenza di una pena esclusivamente punitiva costituiva pura illusione: la pena di morte per molti delitti non esime i cattivi dal continuare a commetterli; per una città è più consona la moderazione e il buon governo per prevenire le azioni malevole.
Un conflitto culturale e ideologico era chiaramente in atto: accanto ai sostenitori, più o meno a oltranza, dell’”occhio per occhio”, stava chi proponeva soluzioni alternative: più specificamente alcuni sofisti e filosofi delle cui opinioni siamo informati grazie ai dialoghi platonici Protagora e Leggi.
 Nel Protagora, dove, il protagonista discute con Socrate sulla questione, vien detto: “Può la virtù essere insegnata?”. E’ questa l’espressione più evidente del perché uno Stato può dare una pena graduata in ogni possibile forma. Per Protagora è chiarissimo che la virtù può essere insegnata: “E se vorrai considerare, Socrate, ciò a cui mira il punire chi commette ingiustizia, questo ti dimostrerà, di per sé, che veramente gli uomini sono convinti che la virtù si possa acquistare. Nessuno infatti punisce coloro che commettono ingiustizie in considerazione e a motivo del fatto che commisero ingiustizia: chiunque, almeno, non si abbandoni a irrazionale vendetta come una belva. Ma chi cerca di punire secondo ragione, non punisce a motivo del delitto trascorso, ma in considerazione del futuro, affinché non commetta nuovamente ingiustizia quello stesso che viene punito, né altri che vedano costui punito”.
Nel Protagora, dove, il protagonista discute con Socrate sulla questione, vien detto: “Può la virtù essere insegnata?”. E’ questa l’espressione più evidente del perché uno Stato può dare una pena graduata in ogni possibile forma. Per Protagora è chiarissimo che la virtù può essere insegnata: “E se vorrai considerare, Socrate, ciò a cui mira il punire chi commette ingiustizia, questo ti dimostrerà, di per sé, che veramente gli uomini sono convinti che la virtù si possa acquistare. Nessuno infatti punisce coloro che commettono ingiustizie in considerazione e a motivo del fatto che commisero ingiustizia: chiunque, almeno, non si abbandoni a irrazionale vendetta come una belva. Ma chi cerca di punire secondo ragione, non punisce a motivo del delitto trascorso, ma in considerazione del futuro, affinché non commetta nuovamente ingiustizia quello stesso che viene punito, né altri che vedano costui punito”.
Evidente nel Protagora la visione di prospettiva della giustizia e una durissima critica al retributivismo. Questa posizione sarà poi il cavallo di battaglia, molti secoli dopo, di Cesare Beccaria ne “Dei dellitti e delle pene”, e nelle opere di Jeremy Bentham. In Protagora, dunque, punire serve sia come deterrenza verso il criminale affinché ripeta lo stesso malfare, sia verso gli altri per evitare che incorrano nello stesso sbaglio.
 L’eterna Atene, dunque, vede il parto dei concetti di pena che si contrapporrano nei secoli successivi, nei momenti in cui il dibattito riemerge appassionato. Interessanti sono le posizioni a favore della pena capitale, di coloro che, cristiani, dovevano sciogliere il dilemma della conciliazione tra la condanna capitale e il divieto di ammazzare. Tommaso d’Aquino (1225-1274) riallacciandosi al principio del bene supremo per il popolo, che anche Cicerone propone in De Legibus, con queste parole cerca di risolvere la diatriba morale: “Il bene comune vale più di quello di un solo individuo. Se, dunque, la vita di certi delinquenti è contraria al bene comune, cioè all’ordine della società umana, essi potranno essere uccisi […] Se l’infezione minaccia tutto il corpo, il medico taglia a buon diritto e utilmente la parte malata; allo stesso modo il Principe, giustamente e senza peccare, mette a morte i delinquenti, nel timore che la pace sociale sia turbata” e aggiunge, per spiegare perché non pecca “[…] nessuno pecca per il fatto che si serve di un essere per lo scopo per cui è stato creato […]. Perciò se l’uomo si serve delle piante per gli animali, e degli animali per gli uomini, non c’è niente di illecito […] È il più necessario dei servizi dare le piante in cibo agli animali, e gli animali agli uomini: il che è impossibile senza distruggere la vita” […] se lo esige la salute di tutto il corpo”, si taglia la parte ammalata.
L’eterna Atene, dunque, vede il parto dei concetti di pena che si contrapporrano nei secoli successivi, nei momenti in cui il dibattito riemerge appassionato. Interessanti sono le posizioni a favore della pena capitale, di coloro che, cristiani, dovevano sciogliere il dilemma della conciliazione tra la condanna capitale e il divieto di ammazzare. Tommaso d’Aquino (1225-1274) riallacciandosi al principio del bene supremo per il popolo, che anche Cicerone propone in De Legibus, con queste parole cerca di risolvere la diatriba morale: “Il bene comune vale più di quello di un solo individuo. Se, dunque, la vita di certi delinquenti è contraria al bene comune, cioè all’ordine della società umana, essi potranno essere uccisi […] Se l’infezione minaccia tutto il corpo, il medico taglia a buon diritto e utilmente la parte malata; allo stesso modo il Principe, giustamente e senza peccare, mette a morte i delinquenti, nel timore che la pace sociale sia turbata” e aggiunge, per spiegare perché non pecca “[…] nessuno pecca per il fatto che si serve di un essere per lo scopo per cui è stato creato […]. Perciò se l’uomo si serve delle piante per gli animali, e degli animali per gli uomini, non c’è niente di illecito […] È il più necessario dei servizi dare le piante in cibo agli animali, e gli animali agli uomini: il che è impossibile senza distruggere la vita” […] se lo esige la salute di tutto il corpo”, si taglia la parte ammalata.
Dunque, l’individuo sta alla comunità come una singola parte sta al complesso, perciò se l’uomo è pernicioso alla collettività, va soppresso in nome del “bene comune” e per spiegare il “buon gesto” della soppressione Tommaso dice: “ […] Sebbene uccidere un uomo che rispetta la propria dignità sia cosa essenzialmente peccaminosa, uccidere un uomo che pecca può essere un bene, come uccidere una bestia. Infatti un uomo cattivo […] è peggiore e più nocivo di una bestia”, anche se per uccidere un uomo serve processarlo. (Bontà sua).
Anche se tale opinione prevaleva, c’era pur sempre chi ragionava diversamente, contribuendo, nel Cinquecento-Seicento, a creare il clima nel quale il movimento abolizionista sarebbe potuto nascere. Per esempio, il filosofo inglese Tommaso Moro (poi condannato a morte e fatto decapitare da Enrico VIII per la sua posizione all’Atto Di Supremazia con cui il re diede corso allo scisma anglicano) nel 1516 scriveva nella sua Utopia: “Iddio ha proibito di uccidere chicchessia, e noi ammazziamo con tanta facilità solo per quattro soldi rubati? Se poi qualcuno interpreta il divieto nel senso che per volontà divina non è lecito dare la morte ove la legge degli uomini non stabilisca di farlo, che cosa ci impedirebbe di istituire fra noi delle norme che consentano in certi casi lo stupro, l’adulterio, lo spergiuro?” (Mereu Italo, La morte come pena. Si può fermare per sempre la mano del boia?, Donzelli, Roma, 2007, p. 69.)
 In Tommaso Moro si evidenzia che esistono due cause del crimine, miseria e ignoranza. Se esse non erano state eliminate chi incorreva in un reato, dunque, doveva essere adeguatamente assistito, con la preghiera e la prigione “aperta”. L’unica eccezione era per i killer assoldati. Un Tommaso Moro cui va riconosciuto un posto storico nelle posizioni pre-abolizioniste che crebbero nel corso del Seicento soprattutto grazie anche al filosofo Blaise Pascal (1623-1662). “È necessario uccidere per impedire che ci siano dei malvagi? […] questo significa farne due invece di uno ” (Pascal Blaise, Pensieri, Michele Ziino (a cura di), Rocco Carabba, Lanciano, 2014, p. 75).
In Tommaso Moro si evidenzia che esistono due cause del crimine, miseria e ignoranza. Se esse non erano state eliminate chi incorreva in un reato, dunque, doveva essere adeguatamente assistito, con la preghiera e la prigione “aperta”. L’unica eccezione era per i killer assoldati. Un Tommaso Moro cui va riconosciuto un posto storico nelle posizioni pre-abolizioniste che crebbero nel corso del Seicento soprattutto grazie anche al filosofo Blaise Pascal (1623-1662). “È necessario uccidere per impedire che ci siano dei malvagi? […] questo significa farne due invece di uno ” (Pascal Blaise, Pensieri, Michele Ziino (a cura di), Rocco Carabba, Lanciano, 2014, p. 75).
Dunque ciò che Beccaria scrisse nel suo “magnum opus” non era stato impresso per la prima volta, però ebbe luce, in un periodo pronto a permearsi di idee innovative e con la voglia di dar loro realizzazione concreta. Il più acceso sostenitore fu Voltaire, che col suo entusiasmo accrebbe moltissimo il successo dell’opera.
La Chiesa mise all’indice il Dei delitti e delle pene, che fu invece tradotto e ristampato in ogni dove europeo (la prima stampa fu a Livorno nel 1764, presso la tipografia di Collettini Marco, ex frate cappuccino lettore della produzione letteraria di Oltralpe, dedito alla poesia, compositore come fu di cantate e melodrammi) e negli Stati Uniti d’America, finendo per essere ricordato come opera che ha spalancato la via al moderno pensiero laico.
Nel volume, Cesare Beccaria confuta l’uso della pena capitale, esamina la proporzionalità della pena, censurando la tortura come inumana e vana. In lui l’influenza di John Loke e Jean Jaques Rousseau è profondissima, soprattutto dove arriva a distinguere tra male e delitto, col riservare solo a quest’ultimo l’intervento legislativo. Il diritto si laicizza, si scristianizza.
Il controllo sociale scaturisce istantaneamente allo stabilire delle regole sociali con norme volte a arginare gli scostamenti, le inosservanze o inadempienze di quelle regole e norme. Si afferma così il concetto che il controllo sociale costituisce lo strumento per stimare le capacità di un gruppo di autoregolarsi. E’ l’arte di armonizzare le forze sociali nella ricerca della tendenza ad un ideale, cioè l’insieme di quei processi che permettono di guidare ed organizzare la soggettività dell’uomo in una comunità. Processi costituiti dai “saperi, poteri, strategie e istituzioni” con cui le élites mantengono un particolare ordine sociale, in un dato periodo storico.
Il controllo, inducendo a un dato comportamento, viene utilizzato per risolvere l’ansia dell’ordine, l’istituzionalizzazione formale e reale dei modi di comportarsi della massa che, grazie ad esso, interagisce fra di essa. Ma esso dipende, in larga misura, dal come gli individui riescono ad introiettare i doveri degli altri coinvolti in questo comune sforzo.
Ora, poiché i fatti sociali si presentano sia in forme usuali e ripetute, sia sotto la forma di correnti nuove, il segreto di un buon controllo sociale sta nel risultato dell’interazione aperta ad ogni tipo di contrattazione usuale e/o nuova, e come gli individui riescono a definire, nella loro concezione di “opinione pubblica”, la realtà collettiva ove operano.
Conseguentemente può apparire che alcuni soggetti percepiscano un dato “ordine” giusto, ed altri, lo stesso “ordine”, un “disordine” pur vivendo ambo le parti nella stessa società. Su ciò incidono le “specie di controllo”, come i valori religiosi, la morale, il diritto, l’arte, la conoscenza, l’educazione, nonché le forme di controllo, autocratico, democratico, e infine le pratiche culturali. Il diritto, dunque, è uno degli strumenti di controllo sociale, ma certamente non l’unico.
Il diritto è creatura contrattata tra lo Stato e i soggetti sociali, che si solidifica e non accetta libere interpretazioni, assumendo la qualità di raccolta organica di norme giuridiche stabili. Ma poiché ci sono vari meccanismi di controllo sociale, frutto di ogni variabile storica, e con influsso variabile sulle diverse condotte sociali, ove c’è libertà l’ordinamento sociale non comprime la personalità, la progettualità e fantasia sociale. Quindi, la composizione dei conflitti e del relativo controllo sociale è, solitamente, costantemente in divenire.
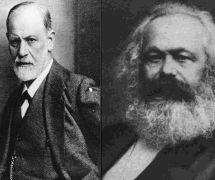 L’homo homini lupus di Hobbes, nella sua più celebre opera Leviathan or The Matter, Forme and Power of a Common Wealth Ecclesiastical and Civil ha generato una guerra perenne di tutti contro tutti, quando è ancora allo stato di natura; allora un furto o qualsiasi atteggiamento violento va dissuaso e questo ha un costo sociale o politico. Ciò non vuol dire che gli uomini sono “cattivi”, ma che i valori e le qualità morali vengono misurate dalle caratteristiche intrinseche nella costruzione dell’ordine sociale, così come i costi e gli effetti di certe scelte comportamentali definiti indesiderati, immorali o illegali.
L’homo homini lupus di Hobbes, nella sua più celebre opera Leviathan or The Matter, Forme and Power of a Common Wealth Ecclesiastical and Civil ha generato una guerra perenne di tutti contro tutti, quando è ancora allo stato di natura; allora un furto o qualsiasi atteggiamento violento va dissuaso e questo ha un costo sociale o politico. Ciò non vuol dire che gli uomini sono “cattivi”, ma che i valori e le qualità morali vengono misurate dalle caratteristiche intrinseche nella costruzione dell’ordine sociale, così come i costi e gli effetti di certe scelte comportamentali definiti indesiderati, immorali o illegali.
Il problema vero è che lo stato di natura non può mai esser descritto come “scomparso”, esso si rinnova costantemente e l’istituzionalizzazione del comportamento sociale abbisogna di costanti e drastici mutamenti, se si vuol superare la “cattiveria” intrinseca nell’uomo di natura. Il Patto va costantemente scritto e riscritto. Una società che non sa farlo sarà sempre una società disordinata e allo sbando di cattiveria e disordine. L’autorità dello Stato dovrà pesare sempre per la parte di libertà che ognuno le delega nel mentre rinuncia ad esercitare i pari diritti di cui è titolare.
John Locke ci dice che gli uomini danno al corpo politico il loro diritto di farsi giustizia da soli e, pertanto, lo Stato deve far ragionare il maggior numero di soggetti, condizionando culturalmente i consociati alla morale del tempo.
Per Hegel la società civile è il mondo dei bisogni e del lavoro, animale selvaggio che abbisogna di continuo e duro addomesticamento e guida da parte dello Stato. Quando l’habitat civile devia è l’intervento dello Stato che subentra, per porre un freno alla confusione dilagante e all’agire arbitrario e nell’interesse soggettivo; vi devono essere corpi sociali in cui i membri siano tutelati, limitando gli individualismi. Corpi che sappiano creare un aggregato in costante dialettica con le altre formazioni sociali. Obiettivo è togliere il movimento atomistico, dando vita ad un agire sociale nell’interesse generale.
Lo Stato è, dunque, la sintesi perfetta tra famiglia e società civile, è il luogo apicale dell’etica, ove l’universale diviene preminente, non negando un’individualità ad ogni suo membro, pur dentro l’unità statuale e senza prescindere da essa.
Ecco allora che il controllo sociale, per molto tempo, è percepito come mezzo preventivo di ogni atto che devii o crei crimine, a disposizione dello Stato per il suo funzionamento e per la pace tra i cittadini. Uno strumento che mira a prevenire ogni eventuale atto deviante e/o criminale.
 Per questo la sociologia si occupa molto del controllo sociale. Un esempio è quello di Durkheim che vede lo Stato “il razionalizzatore” della coscienza collettiva. E’ il sociologo francese, che in controtendenza al tempo in cui visse, evidenzia come il governo democratico, aumentando la comunicazione tra governanti e governati, può dar vita ad un controllo sociale più robusto rispetto ad uno non democratico. Il nodo però è che quest’ultimo, apparentemente, è più forte del primo perché riesce ad imporre al singolo la sua autorevolezza, ma è decisamente debole nel condurre l’organizzazione sociale, che è il vero lato debole del controllo sociale.
Per questo la sociologia si occupa molto del controllo sociale. Un esempio è quello di Durkheim che vede lo Stato “il razionalizzatore” della coscienza collettiva. E’ il sociologo francese, che in controtendenza al tempo in cui visse, evidenzia come il governo democratico, aumentando la comunicazione tra governanti e governati, può dar vita ad un controllo sociale più robusto rispetto ad uno non democratico. Il nodo però è che quest’ultimo, apparentemente, è più forte del primo perché riesce ad imporre al singolo la sua autorevolezza, ma è decisamente debole nel condurre l’organizzazione sociale, che è il vero lato debole del controllo sociale.
La sociologia, quindi, aiuta a comprende che lo studio dell’atteggiamento umano in società serve ad individuare “la coscienza collettiva” su cui si basa l’ordine sociale.
E’ proprio su questo principio che si fonderà la scienza sociale occidentale, che affermerà come il controllo sociale, sia costituito dai rapporti di interazione dei gruppi sociali esistenti, determinati dal processo democratico. Ed è sempre la sociologia Occidentale nord-americana che focalizzando la sua attenzione sulla stampa immigrante, speso politicizzata perché risentiva delle correnti socialiste ed anarchiche dei paesi di origine degli immigrati, arriva ad affermare che, per il crollo delle barriere politiche e culturali, bisogna far evolvere il discorso “immigrante” verso un orizzonte concettuale più ampio e condiviso. In questo caso, dunque, il controllo sociale funziona se in grado di evitare la tensione tra culture, tensione che possa stravolgere gli equilibri dello Stato. Si deve creare, pertanto, un senso comune di ragionare sull’argomento.
 Cesare Beccaria, in “Dei delitti e delle pene”, nel 1764, affermava i principi fondamentali della civiltà giuridica moderna: la proporzionalità della pena, la sua determinatezza, inderogabilità, umanità, la responsabilità penale è personale, l’uguaglianza della parola della legge rispetto ad ogni posizione descrittiva di ceto, genere, razza.
Cesare Beccaria, in “Dei delitti e delle pene”, nel 1764, affermava i principi fondamentali della civiltà giuridica moderna: la proporzionalità della pena, la sua determinatezza, inderogabilità, umanità, la responsabilità penale è personale, l’uguaglianza della parola della legge rispetto ad ogni posizione descrittiva di ceto, genere, razza.
Ma c’è una contraddizione tra l’essere della norma e l’uso fattuale che ne fa chi ogni giorno è demandato a gestire la sopravvivenza collettiva, e la giurisprudenza (il filone si chiama costruttivista) può offrire conoscenze concrete sui fenomeni del crimine, sui suoi processi di costruzione, produzione, riproduzione, che va ben al di là della qualificazione giuridico-normativa. E’ questa l’antitesi della concezione del crimine come problema individuale e la pena come “la” risposta istituzionale ad esso. La costruzione sociale di ciò che è giudicato pericoloso muta e, cambiando, modifica nel profondo chi commette il crimine e la popolazione carceraria. Si pensi alla tossicodipendenza e all’immigrazione.
Con cautela, non si può sottovalutare che in Italia ed in Europa le politiche di lotta contro la droga e l’immigrazione, i senzatetto, i disoccupati, i mendicanti sono un paravento ad una guerra contro le componenti della popolazione percepite, allo stesso tempo, come le meno utili e le più pericolose.
Da qui scaturisce la domanda di sicurezza verso i poteri pubblici, prioritariamente rispetto anche ad altre questioni di più ampia rilevanza sociale, come la disoccupazione. Questa domanda sconfina verso la richiesta di un disciplinamento sociale complessivo, chiedendo l’esercizio di penalità più alte, oppure essa può esser vista anche come una “reale” esigenza di sicurezza sociale. In ambedue i casi si conferma il legame tra percezione di una questione come “socialmente critica” e dilatazione dei confini del penale, il tutto in una spirale non incontrollabile tra “stato di tensione emotiva sociale- amplificazione sotto il profilo mentale dei media-rincrudimento delle pene”.
Questo circolo vizioso manifesta sia la crisi della prospettiva del riformismo penale, sia la concezione beccariana della stessa proporzionalità tra il reato e la pena.
E’ determinante saper capire la costruzione sociale della devianza e del crimine per esaminare e conoscere gli snodi di tale processo. Indispensabile perché dal problema sociale si arrivi alla pena e da questa al “divenire” del problema sociale. Allora, una domanda: tra l’utopia dell’abolizionismo penale e l’illusione repressiva della “tolleranza zero” c’è la terza via di una riduzione dell’area di ciò che è considerato rilevante penalmente, ridisegnando i perimetri tra quello che deve essere penalmente punito e ciò che può e deve essere altrimenti risolto?
Sono convinto che da questo circolo vizioso non si esce se tali perimetri si fondano solo dentro il “diritto”, e non anche entro una più ampia riflessione sociale in grado di andare oltre il tasso autoreferenziale di chi chiede solo più pene e la ferrea applicazione del sistema penale.
 Se è vero che l’azione punitiva legalmente costituita deve stare distaccata dal consenso espresso dalle interrelazioni comunicative della società, se è parimenti vero che la politica non può, per sua natura, prescindere da quel consenso, non si può contestare il fatto che sistema politico, sociale e penale, adottino modi di comunicazione cooperante all’interno della lettera e dello spirito della Costituzione, quale cornice formale-reale dei principi dell’ordinamento.
Se è vero che l’azione punitiva legalmente costituita deve stare distaccata dal consenso espresso dalle interrelazioni comunicative della società, se è parimenti vero che la politica non può, per sua natura, prescindere da quel consenso, non si può contestare il fatto che sistema politico, sociale e penale, adottino modi di comunicazione cooperante all’interno della lettera e dello spirito della Costituzione, quale cornice formale-reale dei principi dell’ordinamento.
Perciò ogni serio pensiero riformista deve battersi per uscire dalla fuorviante dicotomia “più penale-meno penale” e dall’ottica reazionaria in cui il penale si riproduce, amplificando solo se stesso.
In conseguenza di questo, ogni libero pensiero deve chiedersi: “la frontiera che delimita le zone della rilevanza penale va intesa come un rigido confine in balia delle periodiche fluttuazioni di un’opinione pubblica allarmata, o ridisegnata con procedure reali e culturali che sappiano far comunicare “sistema giuridico-sistema politico-sistema sociale”?
E ancora un’altra domanda: in linea con l’evoluzione introdotta da Beccaria, in netto contrasto con le posizioni storiche e attuali della destra reazionaria, l’area del penale può essere rideterminata all’interno del circuito politiche istituzionali, sociali, di prevenzione generale, permettendo addirittura la riduzione del peso delle risorse penali, per la soluzione di problemi di grandissima rilevanza sociale, quali immigrazione, marginalità, devianza minorile?
Premesso che, da tempo, gli studi statistici sulla criminalità ci dicono che i risultati conseguiti nella lotta al crimine, danno tassi di quest’ultimo mai diminuiti per effetto di politiche di pura deterrenza penale, quali politiche sociali, antecedenti al penale, si devono mettere in campo, al di là della illusione repressiva della cosiddetta “tolleranza zero”?
 Personalmente sto dalla parte di coloro che cercano di dare risposte a queste domande, in primis perché faccio parte di questa grande tradizione inaugurata da Cesare Beccaria, poi perché sono contro ogni tentativo di introiettare il seme della paura, perché ciò ferma il processo culturale, ormai irreversibile, sorto nel 1764 e soprattutto perché fortemente convinto che chi semina paura crea solo chiusura fra i meccanismi sociali che devono interagire nel caso. “Togliere la paura” e “uso della forza”, ormai, sono un ossimoro.
Personalmente sto dalla parte di coloro che cercano di dare risposte a queste domande, in primis perché faccio parte di questa grande tradizione inaugurata da Cesare Beccaria, poi perché sono contro ogni tentativo di introiettare il seme della paura, perché ciò ferma il processo culturale, ormai irreversibile, sorto nel 1764 e soprattutto perché fortemente convinto che chi semina paura crea solo chiusura fra i meccanismi sociali che devono interagire nel caso. “Togliere la paura” e “uso della forza”, ormai, sono un ossimoro.





